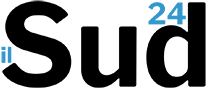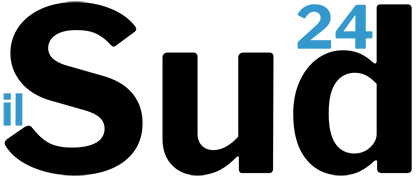Il mito fu tenuto a battesimo il 5 luglio 1984 da settantamila spettatori al San Paolo di Napoli. Lo accolsero senza conoscerlo. Ne erano già innamorati. Arrivava da Barcellona dove lo davano per finito dopo il grave infortunio provocato da una uscita scriteriata di Andoni Goikoetxea, il difensore dell’Athletic Bilbao che spezzò la caviglia a Maradona mettendo fine alla sua carriera nel Barcellona.
Soltanto l’immenso sorriso partenopeo lo avrebbe rigenerato. Al centro del campo prese il pallone e con un calcio potentissimo lo lanciò in cielo. Si unì così a quel popolo che era già “suo”.
La leggenda incominciò a varcare i confini di Napoli e si fece planetaria. Diego Armando Maradona travolse, dal giorno del suo arrivo, tutte le definizioni possibili ed immaginabili, arrivò a far credere ai napoletani che erano cittadini un’altra volta di una nobilissima capitale. Instillò il culto della rinascita in una città decadente e fiera che attendeva un qualche “liberatore”.
Si fece “napoletano”, lui argentino di Buenos Aires, nato nel quartiere più povero, Villa Fiorita, e Napoli da quel giorno è sempre stata la sua casa dove, se le circostanze, spesso tragiche, lo avessero permesso, si sarebbe stabilito per sempre. Ma quel pallone, scagliato con un sorriso stampato sul viso, è rimasto negli anni appeso chissà dove, probabilmente nella fantasia di chi lo accolse come “vendicatore”, rendendosi conto, in poche settimane che tale era, oltre che una sorta di sciamano del calcio, il quale con le sue mirabolanti evoluzioni avrebbe trascinato folle deliranti in tutto il mondo ad amare il fútebol.
Adesso che non c’è più sembra che anche il calcio sia sparito in una mattinata argentina, gonfia di un presentimento durato un mese, dal giorno del suo compleanno, il 30 ottobre, seguito dall’intervento chirurgico al cervello, quando in molti sapevano che da tempo non stava bene, che la sua vita era appesa ad un filo, che il vuoto s’era impossessato di lui costringendolo in una sorta di prigione psicologica.
Si è detto che oggi il calcio è un’altra cosa. Lo è da tempo. Non assomiglia a quello di Maradona, neppure esteticamente oltre che eticamente. Sembra che sia svanita quella gioia contagiosa che il Pibe de oro trasmetteva a chi aveva la fortuna di assistere a qualche partita che spesso vinceva da solo.
Perché il suo non era un calcio “normale”, ma uno spettacolo dalle molte valenze, tra le quali quelle propriamente atletiche non erano dominanti, o lo erano soltanto in parte.
Ho avuto l’impressione vedendolo calciare che volesse dimostrare tante altre cose, oltre alla sua bravura nel battere gli avversari. Per esempio riscattare una città, inorgoglire un popolo, far sentire protagonisti i suoi compagni di ventura.
E così l’impresa di umiliare alla sua maniera l’Inghilterra che aveva scippato al suo Paese le Malvinas fu il solo colpo di cannone che l’Argentina mise a segno raccogliendo intorno a Maradona un popolo che aveva ancora tante ferite aperte. Diego le risanò in un pomeriggio, la “mano de Dios” oscurò le velleità albioniche: delle Falkland nessuno ha mai parlato più, quei due gol che valsero una guerra vittoriosa non ci siamo mai stancati di vederli, il secondo soprattutto, forse il più bello, è stato detto, della storia del calcio.
E il mito cresceva. A Napoli e a Buenos Aires, in ogni angolo del mondo dove le immagini delle sue spettacolari prodezze arrivavano. E si incominciò a porre una domanda, stupida quanto infantile: chi è più grande tra Maradona e Pelé? ‘O Rey, appresa la notizia della morte di Diego, ha detto: «Un giorno spero giocheremo insieme a calcio in cielo».
Chi non vorrebbe esserci in quello stadio dalle parti del Paradiso? Ma noi continueremo a domandarci inutilmente chi è stato il più grande. Sapendo che ognuno risponderà alla sua maniera e la storia del calcio non muterà.
È il cuore che detta le parole, non la mente. Le carriere del brasiliano e dell’argentino sono state asimmetriche. Gli atteggiamenti umani dissimili. I caratteri opposti. L’interpretazione del calcio univoca: genialità, spettacolo e vittoria.
Pelé ha caratterizzato la rinascita di una nazione nel 1958, battendo all’età di 17 anni la Svezia e conquistando la prima Coppa Rimet con cinque gol contro la favoritissima di casa che ne fece soltanto due (Hamrin, poi della Fiorentina, poi del Napoli), dopo la tragedia del “Maracanazo” nel 1950, vittima dell’Uruguay di Obdulio Varela, Schiaffino e Ghiggia.
Maradona non ha soltanto espresso un calcio stellare, bello come quello del brasiliano indubbiamente, ma ha portato i “bassi” napoletani alla ribalta di un mondo che li ignorava; è stato la guida di una vendetta calcistica concretizzatasi nel 1986 all’Azteca di Città del Messico contro di odiati inglesi.
Salì nel cielo messicano il pugno con il quale, da corsaro non meno incallito e impenitente, Maradona acchiappò l’orgoglio britannico e lo trascinò nella polvere.
Fu gol per l’arbitro, uno di quelli che valgono anche se sono falsi perché, al di là del gesto tecnico che lo propiziò, c’era l’avventura di una nazione in quel furto con scasso, il più sublime del football; fu gol per la nazione in delirio che voleva riprendersi la dignità infangata nel 1978 quando il criminale Jorge Videla consegnò nelle mani di Daniel Passarella e di Mario Kempes, l’eroe crinito che piegò gli Orange olandesi alla fine di una estenuante cavalcata con la quale attraversò il campo sulla fascia destra incitato come un gladiatore dagli spettatori, la prima Coppa Rimet conquistata dalla Selècion.
Ma fu la seconda rete, quella della vittoria che consacrò definitivamente il mito. Maradona prese la palla da Burruchaga, se non ricordo male, scartò quattro avversari, con una velocità impressionante che in meno di un minuto lo portò dal centro del campo fin sotto la porta avversaria e calciò curvandosi all’indietro, quasi distendendosi, inchiodando la palla alle spalle di Shilton. Era il 22 giugno: una data che gli argentini non dimenticheranno mai più.
Nel Santos e nell’Argentinos Junior o nel Boca, le storie si sono ripetute centinaia di volte. Pelé e Maradona non sono mai usciti fischiati dal terreno di gioco. Ma a differenza del brasiliano, l’argentino ha fatto qualcosa di più: ha redendo Napoli ed in sette anni l’ha fatta diventare la capitale mondiale del calcio.
Si dirà: due scudetti una Coppa Uefa, una Coppa Italia, una Supercoppa e qualche altro trofeo minore non costituiscono un bottino di guerra che può rivaleggiare con quelli di altre squadre blasonate. Ma c’è da aggiungere che tutto ciò che dal 1984 al 1991 il Napoli ha conquistato porta il marchio di Maradona. Soprattutto la primazia nello splendore di un’improvvisazione senza pari, geniale come un soffio di tromba di Miles Davis.
Lo affiancavano compagni di indubbio valore, ma lui le partite riusciva a vincerle anche da solo. E con la classe, la spregiudicatezza, l’inferno che seminava nelle file avversarie, la simpatia, la strafottenza e l’umanità che dentro e fuori del campo esibiva come un qualsiasi scugnizzo, aveva il dono di far innamorare tifosi e profani: per sette anni Maradona è stato Napoli. Nessun calciatore al mondo può vantare una identificazione con la città del club in cui ha militato come lui.
Neppure Pelé, la cui classe inimitabile è un ricordo indelebile, provocò un’ammirazione che mi conquistò bambino dopo averne visto spezzoni di gioco sul piccolo teleschermo in bianco e nero nel 1958; dopo aver pianto nel 1962 quando s’infortunò nella seconda partita in Cile contro la Cecoslovacchia ed il mondiale lo salvò un altro genio del pallone: il funambolico Amarildo; dopo aver gioito nel 1966 ai Mondiali d’Inghilterra; infine dopo essermi disperato per quell’irripetibile colpo di testa con il quale iniziò le marcature all’Italia, nel solito fatale Azteca, trafiggendo l’incolpevole Albertosi nella semifinale messicana del 1970.
Gli dèi del calcio hanno rapito Maradona troppo presto. Ed in un contesto drammatico, intessuto di interessi, gelosie, rivendicazioni, soldi, eredità. Ma poteva meritare una fine serena il “barbaro” gentile che aveva seminato, il terrore nelle file nemiche? Se ne andato con l’inquietudine nel cuore della quale parlano diffusamente le cronache da ieri pomeriggio.
È come se si fosse voluto sottrarre alle molte sofferenze nascoste senza molto successo. Mi piace credere che abbia afferrato l’occasione che il destino gli ha offerto per legarsi ad essa e conquistare l’ultimo traguardo, l’eternità.
Al cospetto delle divinità pagane del football ci si inchina, non si discute. Il loro trasgressivo passato non inquina valore che è il solo patrimonio che possederanno per sempre. Di tali divinità ne amo tante di un passato ormai lontano. Ma su tutte resta Maradona. Il Comandante. Che mi piace oggi come ieri salutare alla sua maniera, che potrebbe essere quella di un qualunque rivoluzionario, come feci in un caldo pomeriggio di una vita fa, abbracciandolo negli spogliatoi dell’Olimpico dopo una partita con la Lazio: Hasta la victoria siempre.
Gennaro Malgieri
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
- Antitrust, multa da 12,5 milioni di euro a Enel, Sen ed Eni
- Governo, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin: chi sono le ‘stampelle’ forziste del premier
- Conte si salva con una maggioranza risicata, ma ora «ha da passà ‘a nuttata»
- Governo, Rauti (FdI): «Conte si conferma Zelig della politica, c’è bisogno di un governo patriottico»
- Regionali, de Magistris: «Per amore della Calabria mi candiderò»