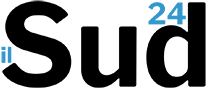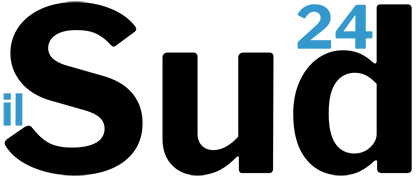Così com’è, dopo tre anni e nonostante i 26 miliardi spesi, ha prodotto solo nuove povertà
Le soluzioni ci sarebbero. Due, quante sono le questioni: il reddito di cittadinanza (da modificare perché sia utile ai cittadini come al Paese e conservare per chi non è in grado di lavorare) e autonomia, più spinose per il governo Meloni.
Forse, non piaceranno ai diretti interessati: i percettori del rdc che per averlo dovrebbero cominciare a lavorare e a quelle regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – secondo le quali il 90% delle tasse pagate dai loro cittadini dovrebbero, indipendentemente dei livelli di eccellenza delle prestazioni e, quindi a danno delle regioni del Sud dove la qualità dei servizi è già più bassa e con meno risorse scenderà ancora di più restare nel proprio territorio – che rischiano di dover ridurre le loro pretese.
Ma – come dimostra l’ennesima frana a Casamicciola – l’Italia, dal Nord al Sud, è condizionata da tre enormi criticità, preesistenti a: pandemia, guerra in Ucrania, crisi energetica, inflazione e rischio recessione.
Mi riferisco: alla povertà che secondo qualche «buontempone» doveva essere cancellata con il reddito di cittadinanza, ma che dal 2019, e con 26 miliardi già spesi, è cresciuta, si è triplicata; alla ridotta funzionalità degli enti locali perché tutti sotto organico; e al degrado ambientale, con città dissestate (come esempio utilizzo quella in cui vivo, Torre Annunziata – oggi ridotta a «bucheria», con più buchi che san pietrini, che Luca Fortis nel 2017 su «il Giornale.it» definì «una bellezza sconosciuta anche a chi ci abita»). Eppure, la Corte dei conti assicura che in cassa ci sono ben 18 miliardi di euro per la manutenzione territoriale, inutilizzati.
Da costo pesantissimo in strumento per lo sviluppo
E allora chiedo, a chi per il ruolo che svolge può provare a dare una svolta ad entrambe le criticità, facendone risorse, se non sia possibile utilizzare il rdc, per dare una risposta in positivo alle altre due. Trasformandolo da costo pesantissimo, in strumento per lo sviluppo. Come? Facendo tesoro di quell’87% di percettori del reddito, cui – a detta di Tangorra commissario dell’Anpal – nessuna azienda potrà mai offrire un posto di lavoro: «perché non sanno né leggere né far di conto», per il recupero e la manutenzione del territorio e delle città e quel 13% che, invece, può vantare un titolo di studio per riempire i vuoti negli organici degli enti periferici.
In modo che, le risorse investite, da un lato, possano aiutare i senza lavoro ad uscire dalla smorta gora della povertà e, dall’altro, tornare utili a rimettere in sesto ambiente e territorio e ripristinare la funzionalità di Comuni, città metropolitane e province. Inoltre restituirebbe ai beneficiari la dignità, consentendogli di portare a casa risorse, non per «grazia ricevuta», bensì quale corrispettivo per il lavoro svolto.
Ovviamente, con il contributo delle aziende del settore che si prestassero a fare da collante, fra governo, occupabili e Inps che dovrebbe provvedere a versare alle imprese la quota del reddito di cittadinanza da aggiungere alla quota dovuta mensilmente dal datore di lavoro per completare la retribuzione piena del lavoratore, potendo fruire anche di assistenza e previdenza sociale. Il tutto, naturalmente, in nome della pubblica utilità.
Benzina sul fuoco
Basterebbe questo a calmare i bollenti spiriti di quelli che protestano contro l’abolizione del reddito? Chissà, in un Paese normale non ideologico, che preferisce il giusto al conveniente, si! Ma in Italia l’ipocrisia dei «seminatori d’odio»: Letta, Landini, Bonelli, Conte & c., continua a gettare benzina sul fuoco, con l’unico obiettivo di far cadere il governo Meloni. Eppure, onestà e buon senso vorrebbero che, per mantenerlo in essere, si schierassero con la sua trasformaziome in reddito per pubblica utilità. Ma lorsignori hanno ben altro obiettivo.
E anche, proposito dell’autonomia, una sintesi sarebbe possibile. A patto che le Regioni del Nord rinunciassero all’egoismo e le meridionali a quella solidarietà di facciata offerta dallo strabismo centralista italiano. Basta vedere da dove siamo partiti nel 1861 e dove ci ritroviamo un secolo e mezzo dopo, per capire il perché. Ciò non significa, sia chiaro, dire «no» all’autonomia, ma preferire la macroregione autonoma dell’Italia del Sud.